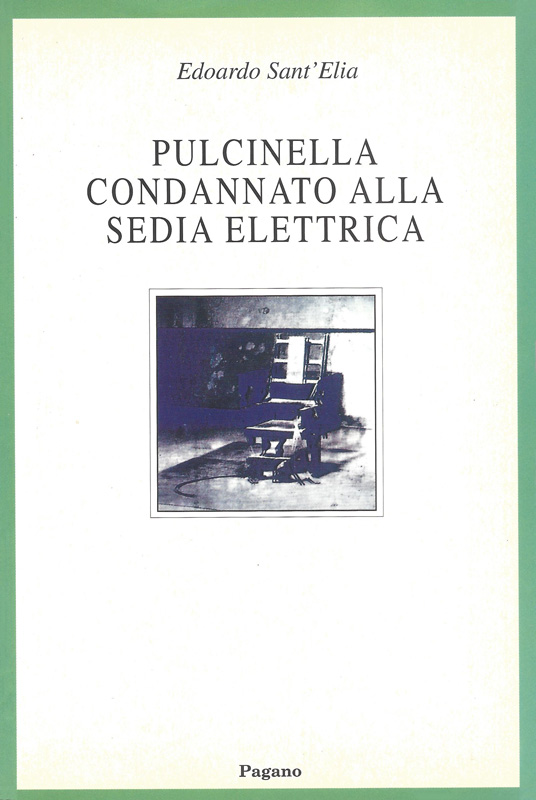da Pulcinella condannato alla sedia elettrica
Napoli, Pagano, 1994
Premessa/scommessa
Una farsa reinventata, dalla scena alla pagina. Un racconto teatrale ‘critico’ che dura lo spazio di una rappresentazione.
Potrà sembrare una bizzarria, dal punto di vista letterario: lo è meno da quello teatrale. Nella storia del teatro copioni, trame, personaggi, sono continuamente recuperati e riadattati, secondo le esigenze dell’autore e dell’epoca. Pensiamo, ricordando solo alcuni degli esempi più celebri, a Molière, che riscrive l’Avaro di Plauto, o ad un personaggio come Don Giovanni, nato in Spagna, sviluppato in Francia, ripreso in Germania, palleggiato tra prosa ed opera.
Questo procedimento creativo io l’ho applicato in un rapporto non di teatro/teatro ma di teatro/letteratura. Sono partito da “Pulcinella condannato alla sedia elettrica”, copione manoscritto rappresentato sui palcoscenici della Little Italy americana presumibilmente agli inizi del ‘900, ed ho tirato fuori un mio Pulcinella, maschera carnosa ma anche elusiva, in bilico tra l’antico e il moderno, tra le sirene cristallizzanti del mito partenopeo e il crudo, disincantato realismo del Nuovo Mondo.
L’ho raccontato, il copione, dall’interno e dall’esterno. Sono entrato nel testo osservandolo con occhio registico, inventando moventi, gesti, atmosfere, per uscirne subito dopo giudicandolo con taglio critico. Ne ho conservato lo scheletro, con la partizione in atti e scene, titolandole come fossero capitoli, ma da queste scene ho pescato, dilatando o riducendo, solo ciò che mi interessava. Ho fantasticato liberamente attorno alle battute, ma quando me ne sono servito nel corso della narrazione le ho trascritte con scrupolosa esattezza, rispettando – e interpretando – i puntini sospensivi come le rivelatrici sgrammaticature.
Il racconto, l’ho detto, dura lo spazio di una rappresentazione. È il tempo ideale, la cornice giusta entro cui tracciare il profilo d’una maschera. Ipotizzare Pulcinella fuori dal palcoscenico sarebbe un esercizio fatuo, retorico. La sua verità, la sua poesia, esistono soltanto lì, filtrate dal muro trasparente, dalla funzionale ipocrisia della ‘quarta parete’.
Atto Primo
SCENA TERZA: compare Pulcinella
Le quinte sono un luogo di spurgo e di passaggio. Dalle quinte si spia, in attesa del proprio turno, ammaestrando la paura, ripassando la parte; si compiono arcani, personalissimi riti propiziatori; si fissano raffinati appuntamenti, in specie gastronomici; ci si allaccia in maniera più convincente le scarpe. Le quinte sono calpestate con rabbia e con gioia, con impazienza e con noia. E si dimenticano in fretta: appena messo piede in palcoscenico.
Difficile immaginare Pulcinella tra le quinte.
Comunque, la terza scena è tutta sua: un assolo da virtuoso, ma senza virtuosismi.
Compare sul luogo del delitto come se provenisse da un altro mondo, da un’altra dimensione. La battuta d’esordio, “Che brutta vita è chesta”, quante volte l’ha pronunziata, quanti echi ha suscitato? Manca qualsiasi artificio nel suo ingresso: nessuno stupore ostentato, nessun colpo di scena lo sottolinea. Nulla dà peso alle parole se non le parole stesse, che suonano lontane e pesanti, srotolate come una stracca cantilena in un dialetto aspro, rugginoso, gracchiante. Pulcinella pare risvegliarsi dopo un sonno interminabile, sembra quasi che abbia sbagliato commedia; i suoi lamenti sono uno sbadiglio lungo, hanno lo stridore ripetitivo di una pianola meccanica suonata a caso, senza spartito, e bisognosa d’accordatore. Nessun imbarazzo – sia chiaro – ed anche nessuna sincerità; piuttosto, uno stilizzato torpore: la maschera scioglie le giunture, prende tempo, non dubitando che la commedia saprà offrirgli spunti comici adeguati.
E intanto parla. Frasi monche, che mastica per ritrovare l’equilibrio, espressioni, elementi che appartengono solo a lui, schegge di un secolare repertorio: favoleggia di “cientumilia ducati”, somma mitologica pescata nei bassifondi della memoria, presa a prestito dai forzieri di qualche antico viceregno, e almanacca che con quella, allora sì, possedendola farebbe la vita del signore e non sarebbe costretto a sollecitare la pietà dei banchieri, che negano perfino una piccola mancia. Pian piano, ecco, prende coscienza del luogo in cui si trova, un palcoscenico americano, un soggetto da portare avanti, e finalmente, con rassegnata accidia, si mette in moto: “Ma se va facenno tardo, lassame portà sto magnà al cav. de Centre Street”. A questo punto, come da didascalia, “(urta nel morto)”.
Che a terra giaccia un cadavere sembrerebbe in effetti pacifico. Solo più tardi, però, e suo malgrado, dietro violenta pressione di altri personaggi, Pulcinella si piegherà ad ammetterlo. Per il momento, con un fastidio che non ha più nulla di torpido ma è un vero e proprio ‘status’ ideologico, rifiuta di arrendersi all’evidenza. L’oscuro, laido legame tra morte e comicità, lo sberleffo come alternativa irriducibile alla tragedia, diviene così la linfa, la spina dorsale e spirituale di una pantomima che vede il cadavere in funzione di silente spalla, riottoso manichino, e la maschera in qualità di sproloquiante protagonista, un protagonista funambolo che arreda il vuoto con le proprie fantasie.
[…]
Atto Secondo
SCENA PRIMA: l’ispezione
In apparenza, qui, c’è poco da ridere. La muffa è autentica, le ragnatele sono ovunque, l’umido si taglia a fette. Siamo nel cortile delle carceri di Sing-Sing: spazio aperto, dunque, in luogo chiuso, un compendio delle scene precedenti.
L’ambiente può tranquillamente identificarsi col teatro stesso. Cosa meglio, infatti, delle semplici pareti di un palcoscenico può rendere il clima ‘fisico’ del cortile d’un carcere? Fondali scrostati, mura spesse con grossi chiodi arrugginiti a cui appendere indumenti scenici o penitenziari di prima necessità, bauli capaci e decrepiti allineati come panche su cui rilassarsi nell’ora d’aria, scale che portano ai camerini e potrebbero condurre alle celle dei detenuti, funi del sipario che sembrano appese in cielo e piovono giù alla rinfusa, beffardo invito alla fuga verso altri impossibili spazi. Il ‘teatro messo a nudo’ si offre come scenografia, espone il suo scheletro, svela i suoi necessari segreti, diviene metafora della reclusione: un mondo fuori dal mondo, coi suoi ritmi, le sue regole.
La vita ‘falsa’ degli attori contro la vita innaturale dei detenuti: disciplina scelta e disciplina imposta. Costrizione a parte, la differenza tra i due ordini non è poi tanta.
Nel cortile è in corso un’ispezione. Il cancelliere Felice, con represso nervosismo, passa in rassegna uomini e strumenti; fungono da interlocutori-parafulmini il policeman Bassicello ed un non meglio identificato ‘Guardiano’. L’atmosfera sospesa, l’insolito ‘horror vacui’ che avvolge i tre personaggi come una seconda pelle e spira a mo’ di venticello venefico con raffiche ravvicinate e sottili, è un effetto secondo delle battute, che procedono cronometriche, impassibili, ancelle gelide di una cerimonia di morte tanto efficiente – almeno sulla carta – quanto priva di sacralità.
La maniacale premura del cancelliere nel fissare punto per punto i meccanismi dell’esecuzione, si incanala naturalmente, trova un argine di molle compattezza nella deferenza laconica e un tantino lugubre del guardiano. Dubbi e perplessità s’infrangono come piccole onde sul petto umilmente roccioso di questo personaggio, che malgrado le poche battute pronunziate non appare affatto privo di personalità, né tantomeno ornamentale nel contesto della messa in scena. La sua vigile presenza va oltre la nota di colore, incastrandosi perfettamente nell’ambiente, sigillandolo, quasi; le risposte che offre, scarne ma efficaci, rispettosamente ovvie, sono chiusure di chiavistello a doppia mandata, bulloni ben oliati che scivolano silenziosamente nel ferro: ed anche balsamo per la sottile angoscia del cancelliere, che ancora dubita del proprio trionfo.
L’intera scena – brusca, strana ispezione dell’ultimo minuto – gira avvitata su sé stessa, ruota nell’attesa di un evento che si cerca di essiccare spiritualmente, di svenare goccia a goccia esaltandone la pura meccanica, mettendo al centro della cerimonia valori neutri come la puntualità: “Ricordatevi che per le 10 precise, il reo deve essere al suo posto.”, oppure traducendo la compassione in precisa componente tecnica: “Siete poi sicuro che tutto l’apparecchio funzioni a dovere e che il condannato non abbia tanto a soffrire?”. L’ansia malcelata del cancelliere, l’estrema concisione del guardiano, l’adesione sia pur sofferta del policeman, concorrono ad un unico fine: sterilizzare, anestetizzare, ottundere.
[…]
Atto Terzo
SCENA TERZA: estetica del guappo
Un piede ben calzato, un profumo penetrante, uno sguardo languido: la scena terza dell’atto terzo ha inizio nel momento in cui varca la soglia della taverna un personaggio che forse avevamo dimenticato: Raimondo, il guappo galantuomo, il fidanzato segreto di Clarice (pupilla del giudice Muller, che invano tenta di concupirla), l’uccisore, infine – dopo regolare e rituale duello – del rivale in amore Florindo Pippo.
È un personaggio che si piace, Raimondo. La sua dizione non può che essere strascicata e nel contempo rauca, come se avesse una puntina di grammofono piantata in gola ad incidere i solchi di una voce lenta, melodica, irritante. Dopo il racconto a soggetto di Pulcinella, tutto mortaretti verbali e scoscese montagne russe, Raimondo è il ritorno all’ordine, alla musica ‘normale’ del copione, modulata da un dicitore arcaico e fatuo che non dubita minimamente del proprio fascino.
Non ha ancora varcato interamente la soglia – il piede, il profumo, il languido sguardo – e già pronunzia la prima battuta, due sole parole che i puntini sospensivi prolungano e fanno echeggiare per l’intera taverna: “Bella Ketty…”. È un complimento giocato con abituale disinvoltura, come chi lanci un fiore tenuto all’occhiello per ogni evenienza; ma l’ostessa, scontrosa con altri, è ora immediatamente lusingata e ritrae d’istinto le unghie mettendosi con femminea gravità a disposizione: “Oh il signor Raimondo, cosa comandate?”. Il guappo per il momento ha un solo desiderio: “Espresso di maccheroni.”. Subito Ketty gli fa eco rilanciando l’ordine verso la cucina, dove scappa con affettata premura, lasciando Raimondo in compagnia di Pulcinella.
I due si squadrano, perplessi; qualcosa, nei rispettivi panni, li attira, li incuriosisce. Si annusano: prima percorrendo la scena in direzioni opposte, il guappo con passo dondolante, quasi sulle punte ma pronto al colpo di tacco, la maschera con ampie falcate, i pollici infilati in un giubbotto immaginario; poi convergono al centro, puntando senza parere l’un verso l’altro, sempre tenendosi a bada con la coda dell’occhio; quindi, dopo essersi sfiorati, giungono apertamente a fronteggiarsi. Il primo approccio è formale: “Addio galantuomo…”, butta lì Raimondo con guardinga supponenza, “Schiavo vostro.”, replica pronto la maschera, ostentando ironica umiltà. Il secondo approccio è più pungente: “Sei animale di questo luogo?”, fa cadere dall’alto il guappo; Pulcinella, dopo aver riflettuto, con eguale spocchia: “E tu sei ciuccio somarino?”. Il terzo approccio frantuma gli argini: “Il tuo volto non mi è nuovo.”, afferma Raimondo con grinta seria; “E la figura toia me pare na mosta de parrucchiere.”, rimbecca senza indugio Pulcinella.
La battuta della maschera dipinge Raimondo dal vivo: un figurino col ciuffo imbrillantinato, le basette a punta, il viso liscio di barba appena fatta, gli abiti attillati all’inverosimile, il gesto ampio e studiato di chi è sempre in guardia e sempre in vetrina. E tuttavia, malgrado la sua tipicità o forse proprio a causa di questa, qualcosa non convince in Raimondo: un pupazzettismo inconsapevole sembra animarlo, le sue battute, immuni da qualsiasi contaminazione dialettale, prive anche di americanismi, sono mutuate dai drammoni popolari dell’italietta ottocentesca, grondano pathos e presunta nobiltà d’animo, stupore ostentato e loquela contorta. Pulcinella, accanto a lui, non può che svolgere con diligenza il tradizionale ruolo di controparte satirica, demistificando in vernacolo gli altisonanti proclami, i fervidi accenti.
Ne vien fuori un dialogo rigido e franto, meccanico e altalenante, come se i due personaggi fossero manovrati dai lunghi fili di un gigantesco burattinaio. La taverna si assottiglia, perde profondità, diviene un fondale dipinto; Raimondo e Pulcinella, fronteggiandosi di profilo, accentuano l’eleganza fatua e il disordine grottesco delle rispettive figure, in bilico sull’orlo del palcoscenico; la puntina di grammofono del guappo e i toni dissonanti della maschera si fondono in un’unica voce che mutando esageratamente i registri srotola a memoria un ingenuo, gracchiante copione.
[…]
Ruggiero Cappuccio
“Il Giornale di Napoli”, 27 aprile 1994
In questo Pulcinella, si procede dalla scena alla pagina, in una sorta di singolare manovra induttiva capace di ruotare intorno al particolare scenico ricamando il preludio analitico sul testo e sui suoi spazi immaginativi. Sono appunto queste frontiere dell’immaginifico a rapire straordinariamente i sensi e la ragione di Sant’Elia, che in questo Pulcinella viaggia con incantato disincanto, ricreando nuovamente la materia esistente, proprio come ogni vero critico o studioso di poesia, letteratura e teatro dovrebbe fare. Pulcinella, questo è veramente notevole, riaffiora da una farsa con l’insolente bellezza della sua indistruttibile natura. Questa, la vera sfida di Sant’Elia: partire dalla contestualizzazione teatrale del Pulcinella più comune e oleografico, per rintracciarvi intatti enormi e inesauste radici storiche, mitologiche, popolari. Il Pulcinella che danza intorno alla sedia elettrica è lo stesso che raggira il boia nel teatro delle guarrattelle, lo stesso che elude la morte nelle storie rappresentative dei burattini. Insomma, anche in una farsa per la Little Italy americana dei primi del novecento, Sant’Elia ha saputo trovare l’atomo originario, che presiede alla natura stessa della maschera.
“Riscontri”, giugno 1994
Così la partitura di Pulcinella condannato alla sedia elettrica è tutta costituita da un’equilibrata progressione timbrica, armonica come di un tema musicale, di una sequenza che si snoda virando, incrociando, modulando, non allontanandosi mai dal centro, malgrado i percorsi laterali, le strategie di pedinamento, le prospettive di osservazione, le conclusioni argomentative; “L’ho raccontato, il copione, dall’interno e dall’esterno. Sono entrato nel testo osservando con occhio registico, inventando moventi, gesti, atmosfere, per uscirne subito dopo giudicandolo con taglio critico”. Le due anime del libro, quella narrativa e quella saggistica, vengono, dunque, a toccarsi, a fondersi, mentre si giustappongono e si intersecano, quasi a connotare una duplice esigenza di parola e di pensiero, di azione e di riflessione, di dramma e di meditazione, in una tramatura contrappuntistica di segmenti discorsivi, di fili logici, con intuizioni poetiche, sensazioni percettive di chi, come Sant’Elia, è vissuto e cresciuto con il teatro, si è formato sul palcoscenico di una finzione/realtà a metà tra mimesi e interiorizzazione, gesto e linguaggio, voce e scrittura: il teatro come luogo, come categoria dell’anima, come itinerario di ricerca intorno all’uomo, al suo farsi personaggio e attante d’una pièce senza fine, senza tempo.
“La voce republicana”, 26 luglio 1994
L’autore scrive nella sua “Premessa/scommessa” di aver voluto tentare una trasposizione, secondo un percorso opposto a quello canonico del Novecento (cioè dalla narrativa alla drammaturgia); eppure il distacco apparente viene tradito da una partecipazione che intona tre diversi livelli della scrittura, li fa agire sullo stesso piano, in una fattiva interazione che contribuisce non poco a fare di questo libro-saggio, ambiguamente teso su generi distanti, una testimonianza poliedrica e viva, sentitamente necessaria, intorno a un antichissimo carattere della nostra commedia dell’arte o della tradizione popolare ancora più lontana nei secoli, quella italica. Questo Pulcinella americanizzato trova oltreoceano la sua giusta distanza per rivelarsi nel pieno delle sue amabili contraddizioni, e a quasi cent’anni dalla stesura del copione, un interprete accorto, disposto a rivalicare mentalmente l’Atlantico per riscoprirne la verità.
“Il Mattino”, 28 luglio 1994
‘Fulminato’ dalla singolarità del testo, Sant’Elia lo ha trasformato in un curioso pastiche, facendo divenire capitoli quelli che nell’originale erano atti e scene; conservando, come dice, lo “scheletro”, ma dentro, nella polpa viva, lavorando alla costruzione di una creatura del tutto nuova. L’operazione, si sarà capito, è squisitamente letteraria: racconto di un racconto, e fantasia multipla. Sant’Elia rispetta fino in fondo il suo copione proprio in quanto lo tira da ogni parte, gli chiede conto di pause e silenzi, ne smonta e rimonta l’irresistibile (proprio perché largamente prevedibile) meccanismo comico, ne gusta le delizie linguistiche – il sapido patois napoletan-americano – e le rilancia in un gioco continuo di appropriazione e spossessamento. Ne risulta una lettura assai godibile e, quel che più conta, nutritizia e illuminante.
“Poiesis”, maggio-agosto 1994
Come Pulcinella che nel finale distrugge la sedia elettrica e si beffa degli accusatori, mangiando i fili come spaghetti, Sant’Elia costruisce una postazione privilegiata per assistere allo spettacolo (della commedia, dell’universo, dell’animo fine e popolare dell’attore?) per poi, in realtà, svelare lungo le pagine che l’osservazione è intorno alla propria scrivania. E la meditazione sulla scrittura – in quanto strumento di analisi del mondo – che viene fuori; sulla pelle stessa di Pulcinella si disegna un tatuaggio ortografico che rivela e giustifica la passione per la decodificazione del Pulcinella condannato alla sedia elettrica di Francesco Ricciardi: testo scritto a mano, zeppo di cancellature e abrasioni, attraversato da svarioni ortografici. Il lettore, di fronte a questo amore confessato, non può che cedere all’incanto, farsi complice.